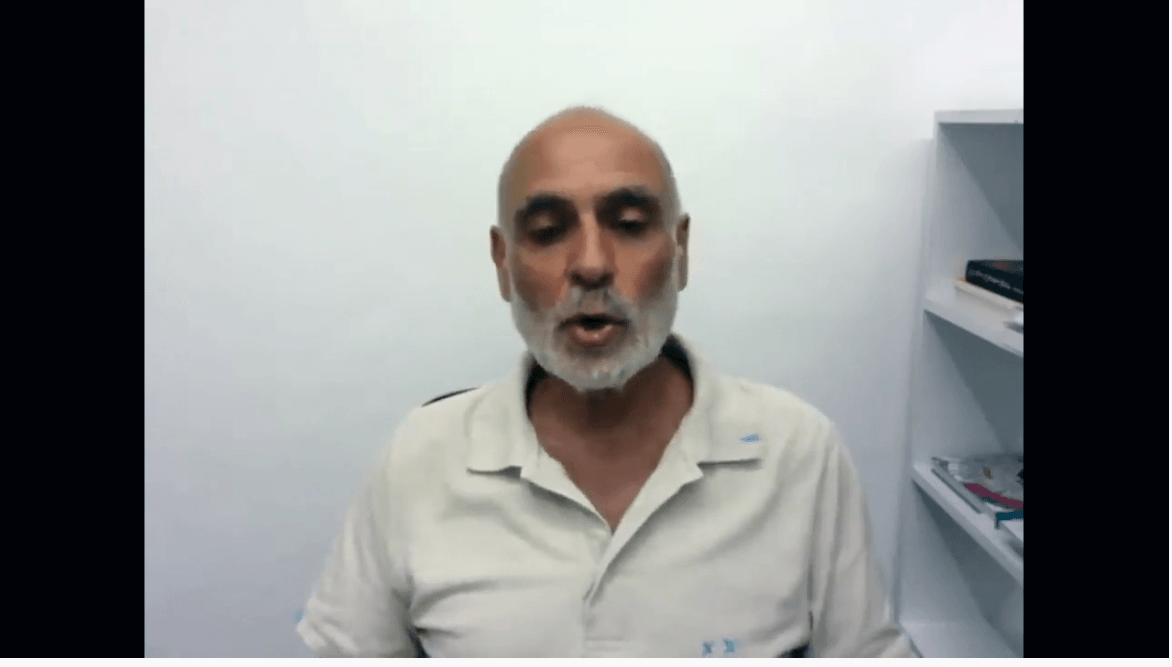L'Istituto
L’Associazione Culturale IBTG
–
Scuola Gestalt di Torino
(già Istituto di Bioenergetica e Terapia della Gestalt) opera da trent’anni nel campo della Psicologia e della Psicoterapia con l’intento di migliorare le relazioni fra l’individuo, il gruppo e l’ambiente, sostenendo i valori umani e una visione della vita più rispondente alle necessità di autenticità e comunicazione.
Proponiamo percorsi formativi per figure professionali quali:
Studenti di Psicologia
Psicologi e Medici
Psicoterapeuti
Titoli Istituzionali
Riconoscimento dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Con D.M. 29.1.02 G.U. n°42 19.2.02
Accreditamento da parte del Ministero della Salute
Per i corsi ECM-Educazione Continua in Medicina l’Istituto è istituzionalmente accreditato come agenzia formativa presso il Ministero della Salute .
Associati al CNSP (Coordinamento Nazionale Scuole Psicoterapia)
Associati alla FISIG (Federazione Italiana delle Società e Istituti di gestalt)
Associati alla CONSAP (Conferenza delle Scuole e Associazioni di Psicoterapia)
Lo staff organizzativo e didattico
Siamo uno staff formato da didatti e allievi didatti che si riconoscono nel modello formativo dell’istituto nonchè nell’approccio della terapia della gestalt.
Lo staff è composto da professionisti che si sono formati e continuano a sviluppare un modello teorico e pratico di intervento anche su specifici temi, quali: l’intervento in età evolutiva, la dimensione della sessualità, l’intervento terapeutico centrato sul corpo, la psicopatologia gestaltica, il lavoro di co-conduzione.
IL COLLOQUIO CLINICO PSICOLOGICO:
FORMAZIONE PRATICA
FORMAZIONE PRATICA
Diventare psicologi significa avere in mano una professione che ad oggi sembra non offrire gli strumenti necessari per iniziare a lavorare come funzione di supporto nelle relazioni di aiuto.
In realtà non è così: occorre esplicitare gli strumenti imparati durante i corsi universitari e farli diventare propri, ovvero fare esperienza della teoria.
In questo corso professionalizzante ci proponiamo questo: recuperare gli strumenti necessari ad affrontare un colloquio clinico di sostegno e permettere ai partecipanti di praticarlo, attraverso role-play e sedute dal vivo con i partecipanti del corso.
PERCORSO
Affronteremo nel dettaglio alcuni temi, inseriti nella cornice teorica della terapia della Gestalt e li tradurremo in esperienze pratiche guidate e sotto supervisione dei docenti.
CONOSCI LA NOSTRA RIVISTA?
La rivista si propone di diffondere la pratica e la teoria della Scuola alla comunità gestaltica e ai professionisti di orientamento diverso. La rivista nasce dall'esigenza, molto sentita, di condividere esperienze e prassi di lavoro inquadrandole in un discorso teorico contemporaneo.
Siamo interessati alla clinica in senso stretto quanto all'applicazione della gestalt nel sociale e nelle organizzazioni. È nostro desiderio ospitare contributi da parte di autori interessati a creare con noi un contatto.
La Gestalt ha radici nella filosofia fenomenologica ed esistenziale e nella Teoria della Gestalt, ma non appartiene né alla psicologia né alla filosofia, bensì all’arte dello stare in relazione.
Ultimi articoli

Perls, uno dei fondatori della Gestalt, sosteneva che la Terapia della Gestalt non è né una terapia corporea, ma neanche una terapia verbale. Non è una terapia corporea perché non propone esercizi con l’obiettivo di forzare corazze muscolari, né si sviluppa attraverso l’uso di massaggi con lo scopo di agire sui tessuti connettivi profondi e rilassare gli spasmi muscolari, come ad esempio fa il Rolfing. Non è una terapia verbale perché non lavora primariamente sui contenuti verbali (“cosa”) e sulla storia del paziente, ma si concentra sui processi e sul “come”. Uno degli obiettivi della formazione in Gestalt è l’"osservazione fenomenologica": un’attitudine (“epochè”) che consiste nel mettere tra parentesi giudizi e interpretazioni, per concentrarsi su ciò che viene colto attraverso i sensi. Oltre ad ascoltare le parole, osserviamo i gesti del paziente, come si muove, come respira, come/quando blocca il suo respiro, se arrossisce, il tono di voce, posture.. e tutto ciò che colpisce l’attenzione del terapeuta nel qui e ora. Rientra nell’osservazione fenomenologica anche il corpo e il “sentire” dello stesso terapeuta, le sue sensazioni, i suoi movimenti, paure, emozioni, ecc. A cosa ci serve l’osservazione fenomenologica quando siamo in seduta? Ha una funzione educativa perché alleniamo il paziente a concentrarsi sul qui e ora, e a riconoscere le sue fughe nel passato o nel futuro. E’ solo nel presente che il paziente può trovare la calma necessaria per affrontare i problemi, apprendere modi nuovi di vivere le relazioni, cioè nel momento in cui si permette di farne esperienza. Allenandosi ad ascoltare il corpo, il paziente impara ad accogliere ed eventualmente anche a descrivere i vissuti emotivi attraverso le sensazioni corporee piuttosto che attraverso le credenze e i giudizi su di sé e sul mondo. Questo è già un primo passo verso il cambiamento. Inoltre l’attenzione alle sensazioni ha un effetto calmante perchè riporta la mente sul qui e ora. Infine, grazie alla concentrazione sul qui e ora possiamo lavorare sul “contatto” e sulle “interruzioni di contatto”, che è il cuore della Gestalt: il terapeuta facilita la creazione di un tempo e di uno spazio in cui la figura è il contatto, cosa sta succedendo tra paziente e terapeuta, come si stanno incontrando, e su quali comportamenti nevrotici si stanno appoggiando per abbassare il livello d’ansia che ogni novità presuppone. Questa è l’essenza della terapia della Gestalt, quando afferma che la sofferenza nasce in una relazione e soltanto in una nuova relazione potrà essere curata: grazie a nuove esperienze, il paziente può prendere il sostegno che gli serve per recuperare il suo potenziale e le risorse bloccate,

La terapia della Gestalt lavora con i sogni considerandoli come espressioni importanti della vita interiore e relazionale dell'individuo. Nella Gestalt, i sogni non sono visti solo come manifestazioni notturne, ma come esperienze significative che possono rivelare desideri, conflitti e parti inespresse del sé. Ecco come generalmente funziona questo approccio: 1. Esplorazione del sogno: Il terapeuta invita il cliente a raccontare il sogno in dettaglio. Questo include la narrazione degli eventi, le emozioni provate e i personaggi coinvolti. 2. Identificazione degli elementi del sogno: Ogni elemento del sogno (persone, luoghi, oggetti) può rappresentare diversi aspetti della personalità del sognatore. Attraverso tecniche come il "gioco di ruolo", il cliente può esplorare e interpretare questi elementi, dando voce ai loro significati. 3. Focus sull’esperienza presente: La terapia della Gestalt enfatizza il "qui e ora". Il terapeuta incoraggia il cliente a connettersi con le emozioni e le sensazioni corporee che il sogno suscita nel presente, aiutando il cliente a comprendere il significato del sogno in relazione alla sua vita attuale. 4. Autenticità e consapevolezza: L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e l'autenticità del cliente. Attraverso l'analisi dei sogni, il sognatore può confrontarsi con parti di se stesso che potrebbero essere state ignorate o represse, facilitando la crescita personale. 5. Integrazione: Infine, il lavoro con i sogni può portare a una maggiore integrazione delle parti del sé e a un miglioramento della consapevolezza di ciò che il cliente desidera o teme nella vita quotidiana. Questo approccio ai sogni permette quindi di estrarre significato e di lavorare attraverso questioni emotive, facilitando un processo di guarigione e di sviluppo personale.
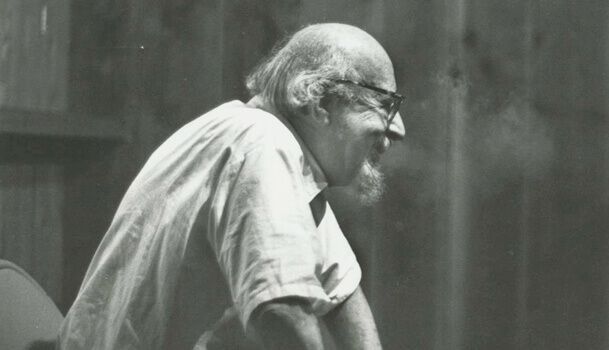
Fritz Perls, uno dei fondatori della terapia della Gestalt, aveva un modo unico di lavorare con i sogni, considerandoli come porte d'accesso alla consapevolezza del sé e a contenuti emotivi profondi. Ecco alcuni principi chiave su come Perls affrontava i sogni: 1. Sogno come realtà: Perls considerava il sogno come un'esperienza vivente che rifletteva la realtà interna del sognatore. Non lo interpretava in modo tradizionale, come un simbolo da decifrare, ma piuttosto lo Paragonava a un “dramma” che avveniva nella vita del sognatore. 2. Tecnica del "tu sei": In una sessione di terapia, Perls spesso incoraggiava il cliente a “essere” ogni parte del sogno. Questo significa che se il cliente parlava di una figura nel sogno, veniva invitato a impersonificarla e a esprimere i suoi sentimenti e pensieri. Questo aiuta a esplorare diversi aspetti della personalità e a far emergere emozioni nascoste. 3 . Focus sul presente: Perls credeva che, lavorando con il sogno, i clienti potessero diventare più consapevoli di ciò che stava accadendo nel loro presente. La rielaborazione dei sogni porta spesso a capire come le esperienze oniriche si riflettono nelle dinamiche della vita quotidiana. 4. Emozioni corporee: Parte dell'approccio di Perls consisteva nel connettere i sogni con le sensazioni corporee. Incoraggiava i pazienti a prestare attenzione a come si sentivano fisicamente quando parlavano del sogno, utilizzando queste sensazioni come chiave per esplorare emozioni più profonde. 5. Risoluzione dei conflitti: Attraverso il lavoro sui sogni, Perls cercava di aiutare i clienti a riconoscere e risolvere conflitti interni, permettendo loro di affrontare paura, desideri e parti di sé che erano state trascurate. In sintesi, Fritz Perls utilizzava i sogni come uno strumento potente per il lavoro terapeutico, promuovendo la consapevolezza e l'integrazione delle esperienze interiori , e facilitando un maggiore contatto con il proprio sé autentico.
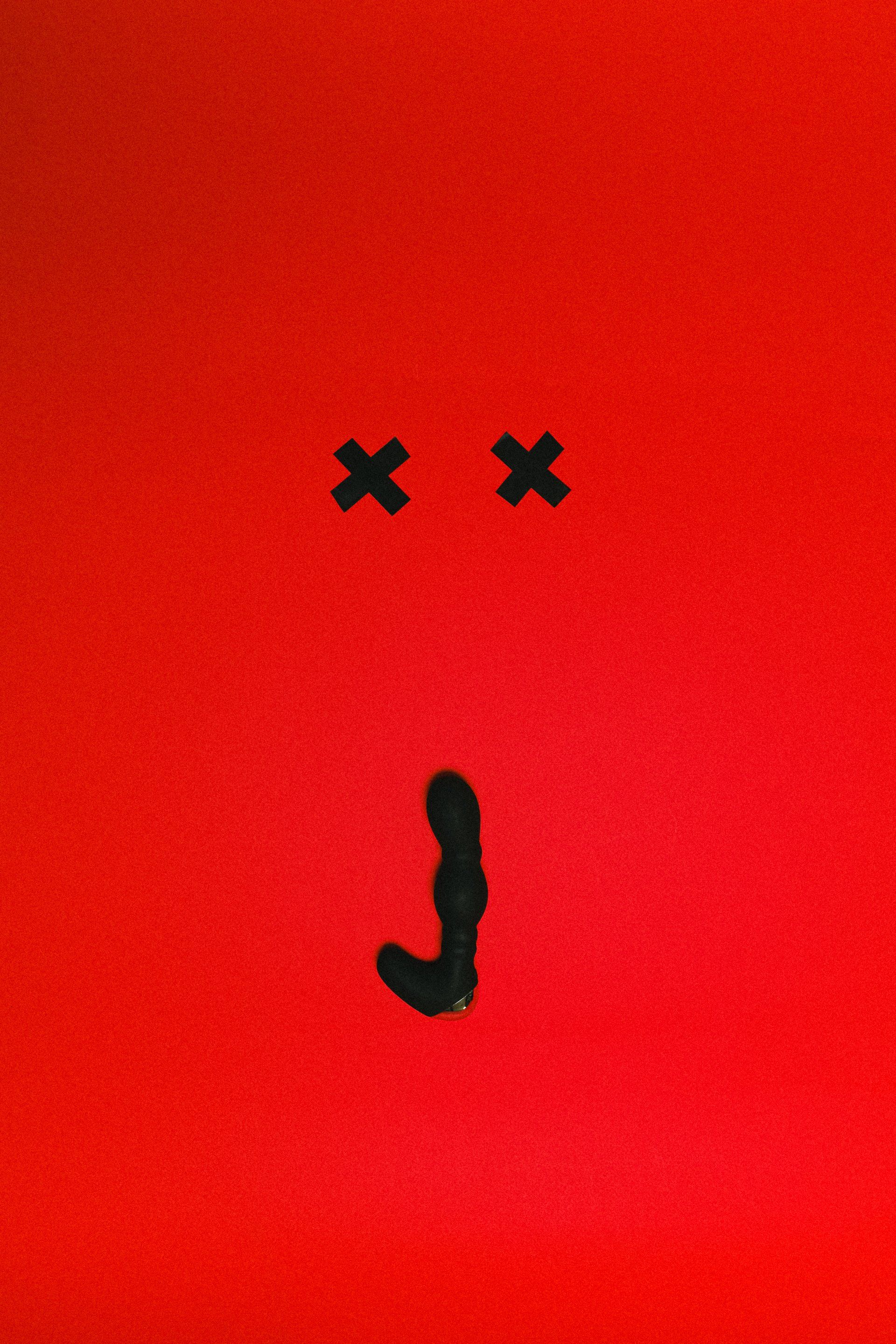
Le rivoluzioni sessuali hanno cercato di “liberare" la sessualità dai controlli delle chiese, degli stati, delle famiglie, delle culture dominanti. Rendere cioè la sessualità un fenomeno relazionale libera di autoregolarsi all’interno di una relazione paritaria finalizzata al piacere, alla soddisfazione e alla cura reciproca. Abbiamo visto che questo obiettivo non è stato ancora raggiunto, neanche nei paesi a cultura eurocentrica, ma la direzione è condivisa, almeno a livello teorico, da fette di popolazione sempre più ampie. Quello che però non si è ancora fatto è “metaforizzare” i genitali. Considerare cioè i genitali non più solo come organi copulatori, da utilizzare solo nel momento che si decide di avere un rapporto genitale, ma come centro organismico di una spinta verso il mondo, verso la vita, basata sul piacere, la soddisfazione e la cura reciproca. Questa metaforizzazione in realtà esiste già, ma solo per i testicoli dell’uomo che nella cultura patriarcale sono diventati simbolo di coraggio, forza e determinazione. “Tirare fuori le palle”; “Ha le palle di ferro”; “Non ha le palle”, sono tipiche espressioni per indicare coraggio, forza e codardia. Ma in queste metafore non esiste il piacere, non esiste la soddisfazione e non esiste la cura. Le palle dell’uomo diventano simbolo di dominanza. Sulla donna in primis, ma anche di un uomo su un’altro uomo che non soddisfi i criteri di coraggio, forza e dominanza del patriarcato. La sessualità vuole l’unione, il piacere, la cura reciproca, la creatività. Richiede una competenza ancora inconsueta: imparare a radicarsi nei genitali, trovare in questo contatto intracorporeo il sostegno per portare/cercare nel mondo unione, piacere e cura. La bioenergetica ci ha insegnato il radicamento attraverso i piedi, metafora delle radici che ci collegano alla terra. Il cuore è il centro dell'amore. I denti sostengono la masticazione critica di concetti ed esperienze (Perls, 1942). E così via per moltissimi organi, eccetto per l'apparato sessuale che viene metaforizzato solo per esprimere la dominanza maschile della cultura patriarcale ("Mi hai rotto i .. Sei una testa di .. " ecc.). Respirare nei propri genitali, imparare a sentirli, ad appoggiarsi ad essi all’interno di una cultura di rispetto, cura e piacere reciproco è la prossima tappa della rivoluzione sessuale. Nelle scuole vuol dire promuovere esperienze attraverso cui bambini e bambine imparino a conoscersi e non vergognarsi dei genitali, a tenerli nascosti o, al contrario, esibirli per provocare o disprezzare l’altr*. Vuol dire iniziare a nominarli e invitare i bambini a descrivere come sono fatti, toccandosi. Questo non vuol dire invitarli a masturbarsi in classe, è proprio questa l’ignoranza che dobbiamo superare: quella di identificare gli organi genitali esclusivamente con la funzione della masturbazione o copulazione, in una visione in cui la sessualità è appiattita alla scarica genitale ed è scollegata dalle relazioni.